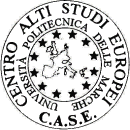La commissione Industria, ricerca ed energia (Itre) del Parlamento europeo ha confermato con 38 voti a favore, 20 contrari e 6 astenuti l’accordo raggiunto con il Consiglio Ue lo scorso 7 dicembre sulla revisione della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici.
C'è un primo "sì" dell'Eurocamera al testo finale - frutto dei negoziati tra lo stesso Parlamento, la Commissione e il Consiglio - sulla direttiva che introduce obblighi per la ristrutturazione degli immobili europei con l’obiettivo di renderli più sostenibili per l’ambiente. La commissione Industria, ricerca e energia (Itre) del Parlamento europeo ha infatti approvato il provvedimento con 38 voti a favore, 20 contrari e 6 astenuti. Perché il testo entri in vigore manca solo l'ok finale della Plenaria. Il provvedimento sarà calendarizzato in una delle prossime sessioni, presumibilmente nel mese di marzo.
La revisione della direttiva case green è stata proposta dall’Esecutivo comunitario a dicembre 2021 per alzare gli standard energetici del parco immobiliare dell’Ue, dal momento che gli edifici sono responsabili di circa il 40% del consumo energetico europeo e del 36% delle sue emissioni di CO2. Nell’accordo finale i negoziatori hanno ammorbidito parte delle richieste iniziali della Commissione europea per andare incontro alle richieste di Paesi come l’Italia, dove la proposta ha alimentato un’aspra polemica soprattutto per quanto riguarda la parte relativa ai finanziamenti e agli standard minimi di prestazione energetica. L’impianto generale della proposta della Commissione europea viene conservato e dunque a partire dal 2030 tutti i nuovi edifici residenziali dovranno essere costruiti per essere a emissioni zero. Per gli edifici pubblici, questo standard si applicherà a partire dal 2028. Entro il 2050 l’intero patrimonio edilizio esistente dovrà a emissioni zero.
Al centro della proposta della Commissione c’erano però gli standard minimi di prestazione energetica, con cui Bruxelles aveva proposto di inserire un obbligo di ristrutturare almeno il 15% degli edifici con le peggiori prestazioni in ciascun paese dell’Ue. I negoziatori hanno confermato di volersi lasciare alle spalle l’idea di inserire requisiti di ristrutturazione dell’Ue per i singoli edifici basati su classi energetiche armonizzate, preferendo un approccio in cui vengono stabilite le medie di riferimento per ciascun Paese sull’intero patrimonio edilizio.
Per gli edifici non residenziali, i negoziatori hanno stabilito che almeno il 16% degli edifici con le peggiori prestazioni sarà destinato alla ristrutturazione entro il 2030 e il 26% entro il 2033. Quanto agli edifici residenziali, le case, si applicherà un obiettivo medio settoriale di riduzione dell’energia, con una riduzione del consumo energetico del 16% nel 2030 e del 20-22% entro il 2035.
Per garantire flessibilità ai governi, le misure di ristrutturazione adottate dal 2020 saranno conteggiate ai fini dell’obiettivo ed è prevista una clausola aggiuntiva che mira a premiare “gli sforzi iniziali”, ovvero premia gli Stati membri che hanno adottato misure tempestive. L’accordo prevede inoltre una serie di esenzioni che gli Stati membri possono applicare per gli edifici storici, per gli edifici agricoli, per scopi militari e, ancora, edifici utilizzati solo temporaneamente.
Tra i dettagli stabiliti nel corso del negoziato interistituzionale è stato posticipato dal 2035 (come da proposta dell’esecutivo comunitario) al 2040 l’obbligo di dire addio alle caldaie alimentate da combustibili fossili per il raffrescamento e riscaldamento delle case, una questione cara anche all’Italia. I co-legislatori hanno inoltre concordato di porre fine a tutti i sussidi per le caldaie autonome entro il 2025. Una volta confermato l’accordo e pubblicato in Gazzetta, l’attuazione delle norme dovrebbe iniziare nel 2026.